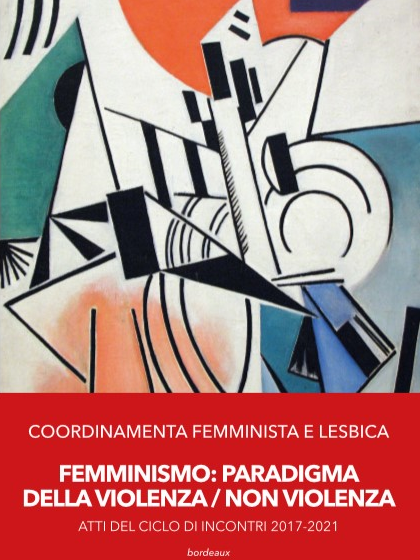Podcast della presentazione del 29 maggio 2018 al Nido di Vespe del libro
<E questo è quanto>”Salvatore Ricciardi” di Ottone Ovidi ed. Bordeaux
29 maggio/E questo è quanto, storie di rivoluzionarie e rivoluzionari
Questa la registrazione di tutta l’iniziativa
clicca qui
Questo l’intervento di Barbara Balzerani
Mi piace molto l’impostazione che Otto ha dato al suo libro. Credo che la storia sia una materia da storici, quelli che si documentano, che mettono a confronto le fonti, quelli che non dovrebbero sbagliare una virgola rispetto a quanto raccontano. Invece la memoria è personale, ruota attorno alla figura di una persona – in questo caso Salvatore – può avere degli svantaggi, magari soffrire di qualche défaillance nei ricordi o, peggio, essere in seguito rielaborata in modo diverso rispetto ai fatti vissuti e a quello che si pensava nell’atto di compierli. E spesso succede. Però, il modo di raccontare attraverso la memoria individuale ha un enorme vantaggio secondo me, e cioè restituisce una fisionomia, carne e sangue a figure che altrimenti rimarrebbero astratte e stereotipate. Come è successo a quella del “brigatista”. Salvatore è portatore di una storia sua, particolare e, contemporaneamente, collettiva che ci offre uno spaccato sull’origine sociale e il percorso di militanza della stragrande maggioranza dei militanti di quella che è stata la nostra organizzazione. E questo è un aspetto fondamentale, proprio perché la figura del brigatista è stata mostrificata, censurata e condannata, in realtà più dalla propaganda che dagli storici, visto che qualche buon libro si può trovare nell’omologazione pressochè totale alle verità ufficiali di tv, cinema, giornali. La propaganda del potere ci ha riempiti di fango. Secondo la vulgata massamediata non si capisce da dove siamo venuti, chi siamo, quale famiglia marziana ci ha messo su questo pianeta, essendo stati del tutto estranei alle dinamiche sociali di questo paese. È un tamtam che va avanti da trenta, quaranta anni, ed è riuscito ad entrare nel senso comune, a far passare l’idea di quattro matti che una mattina si svegliano, vanno a via Fani, fanno una strage, spalleggiati da molteplici poteri occulti.
Nell’apice di questo delirio di mistificazione rappresentato dal quarantennale del sequestro Moro, purtroppo non mi pare che gli storici siano stati tanto presenti come avrebbero dovuto e potuto, indicando altre prospettive di analisi e conoscenza rispetto al discorso mediatico. Al contrario abbiamo visto giornalisti mediamente informati fingere di non sapere, ignorare fatti più che noti, fare “errori” che scivolano nell’orrore, arrivando persino a dire che noi avremmo ammazzato dei compagni… queste sono state le cose dette in televisione… Si è arrivati ad un piano di discussione talmente immiserito che non si tratta neanche più di una contestazione nel merito dei fatti accaduti. Se così fosse, già sarebbe qualcosa, ci attesteremmo almeno su un piano dialettico, di confronto tra diverse posizioni rispetto ai fatti. Invece siamo all’insulto, un insulto gridato che non lascia margini a nessuna possibilità di contestazione.
Rispetto a questo discorso mediatico dominante, cosa fa l’accademia abilitata all’insegnamento e alla critica storica? Possiamo solo prendere atto dello stato in cui versa: qualche giorno fa, all’università di Tor Vergata, un programma di dottorato in storia ha ospitato un’iniziativa che ha riunito membri dell’ultima commissione parlamentare e dietrologi, praticamente una sola e univoca voce. Come è possibile ricostruire la storia se questi ne sono i presupposti e le linee di discussione? Perché dovremmo avere interesse e voglia di confrontarci con questi signori, i quali da una parte dicono che dobbiamo tacere, e dall’altra che siamo reticenti? E’ un gioco miserabile, però funziona, e attecchisce, tanto in chi in quegli anni non c’era e crede di sapere, come in chi invece c’era e ha “dimenticato”, perché anche l’aver cambiato idea così radicalmente da fingere di aver visto e vissuto cose diverse da quelle accadute contribuisce a mistificare il racconto. Su questa strada diventa gioco facile far passare verità imposte che parlano la lingua del potere che si protraggono ormai da qualche decennio e che da quando è stata istituita la “giornata della memoria delle vittime del terrorismo” va sotto il nome di “memoria condivisa”.
Cosa significa memoria condivisa? Come si fa in una società divisa in classi ad avere una memoria condivisa? E’ una contraddizione in termini. Ciò che dice Otto nella sua prefazione, e cioè che la sua è una scrittura di parte, è il minimo che si debba dichiarare e da cui si debba partire credo, proprio perché non esiste una storia asettica, non esiste una storia obiettiva. Esiste al contrario una storia ufficiale che non è affatto neutrale, perché esprime il punto di vista padronale, in questo caso capitalistico, e che non lascia spazio a niente altro. In ogni caso, non esiste nessuna possibilità di mettere insieme narrazioni che esprimono interessi di classe diversi e che procedono nella ricostruzione della propria storia secondo modalità diverse. Continua a leggere




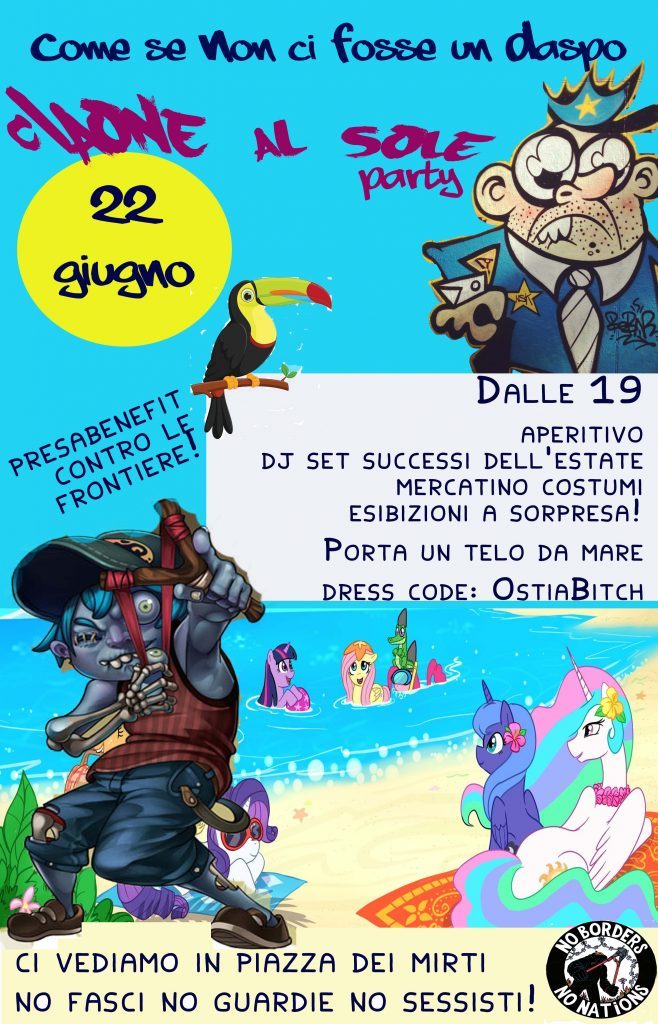
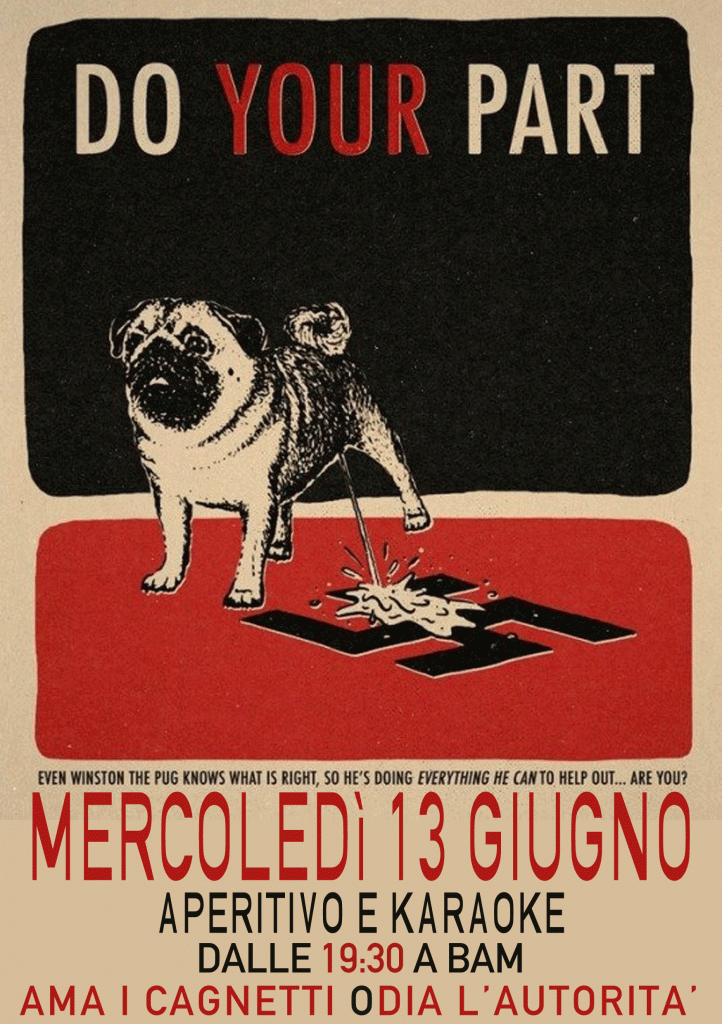
 Noi siamo otto donne che hanno deciso di scrivere e pubblicare questa brochure. Otto donne dai venti ai settantaquattro anni. Alcune di noi hanno dei figli, altre no. Quello che ci unisce non è il fatto di essere madri o meno, ma il fatto di essere, come donne in questa società, tutte attraversate dalle questioni della maternità. Quello che ci unisce è anche che non ci piace questo mondo com’è e che vogliamo agire contro tutte le dominazioni e le oppressioni e, dunque, tra le altre, contro il patriarcato. L’avvio per il nostro riflettere collettivamente ci è stato dato dalla storia di una donna gettata in prigione per infanticidio. Questo ci tocca e ci interroga. Ci fa rivoltare inoltre quando la stampa si scatena presentando le donne infanticide come dei mostri, tuttalpiù come delle malate.
Noi siamo otto donne che hanno deciso di scrivere e pubblicare questa brochure. Otto donne dai venti ai settantaquattro anni. Alcune di noi hanno dei figli, altre no. Quello che ci unisce non è il fatto di essere madri o meno, ma il fatto di essere, come donne in questa società, tutte attraversate dalle questioni della maternità. Quello che ci unisce è anche che non ci piace questo mondo com’è e che vogliamo agire contro tutte le dominazioni e le oppressioni e, dunque, tra le altre, contro il patriarcato. L’avvio per il nostro riflettere collettivamente ci è stato dato dalla storia di una donna gettata in prigione per infanticidio. Questo ci tocca e ci interroga. Ci fa rivoltare inoltre quando la stampa si scatena presentando le donne infanticide come dei mostri, tuttalpiù come delle malate.
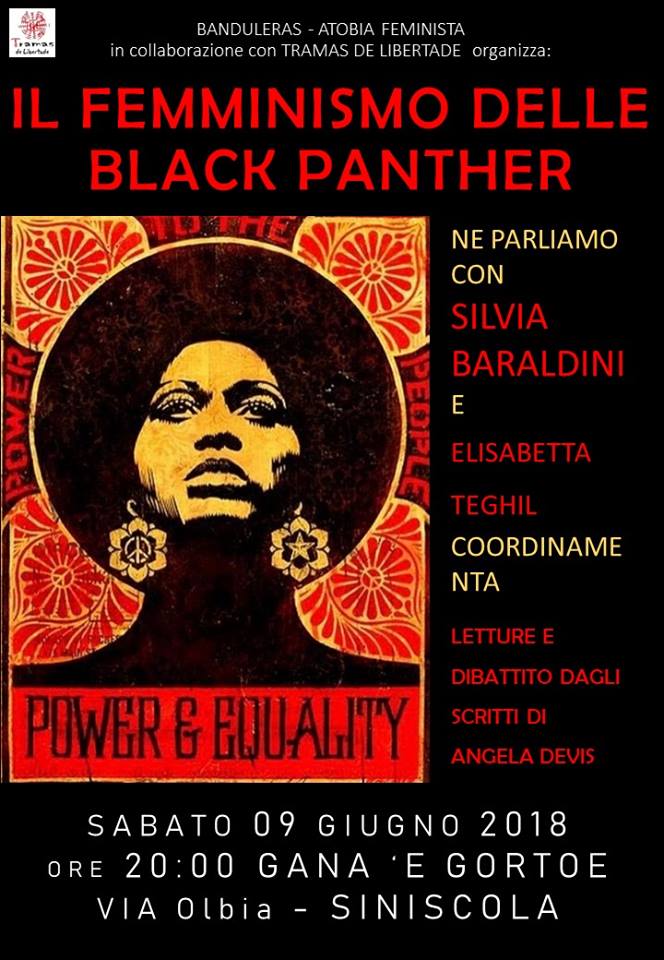




 Parentesi del 21/o5/2014
Parentesi del 21/o5/2014