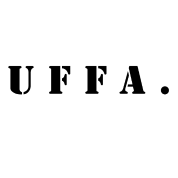Da “I Nomi delle Cose” del 24/2/2016 “Desmonautica“ la rubrica di Denys ogni ultimo mercoledì del mese.
“La difficoltà di avere difficoltà”
clicca qui
Ho difficoltà a fare molte cose.
Non so condividere i miei spazi, non senza impazzire. Non so cominciare e finire le cose con facilità. Non me la cavo granché col linguaggio del corpo e le sottili implicazioni emotive dei messaggi sottintesi. Non sempre riesco a comunicare a voce, e anche quando posso, avverto un enorme peso nel tradurre le mie immagini in lessico intellegibile. Non posso tollerare i programmi stravolti di punto in bianco. Non so gestire più di un impegno al giorno, massimo due, per le mie energie limitate e per via dell’angoscia e del disorientamento che mi porta la gestione simultanea o sequenziale delle mie istanze quotidiane. Non esco molto di casa perché mutare spesso ambientazione mi stressa molto. Non ho realmente idea di come ci si faccia delle amicizie, o di come si manutengano i rapporti umani: devo i miei residuati di socialità a tutte quelle persone che fanno lo sforzo di perseguire la mia compagnia. Ho bisogno di fare tutto sempre allo stesso modo e di obbedire a piccole e grandi compulsioni utili e inutili che non sono dettate dallo sfogo di un’ossessione ansiosa ma da un’innata, non estirpabile, tendenza alla routine, e non posso non ammettere che mi sento a disagio nel continuare questo paragrafo rompendo lo schema che mi fa iniziare le frasi con un bel non. Ho dei sensi che funzionano in modo intenso e bizzarro, offrendomi la capacità di causarmi disgusto fino al vomito di fronte a molti sapori e consistenze; sentirmi benedetto sulla terra per le deliziose, friabili onde sonore di tarallo masticato sull’autobus dalla passeggera dietro di me; scoppiare in una immensa crisi di rabbia notturna graffiandomi le braccia e sbattendo la testa contro il mobiletto del bagno per via della irritante frequenza dei miei che russano e dell’insopportabile nenia di slinguazzamento che fanno i gatti nei loro riti di toelettatura, poiché dormiamo nella stessa stanza da vent’anni con buona pace del mio ineluttabile bisogno di privacy; avvertire la benché minima variazione di temperatura dunque non riuscire a tenere in mano una tazza moderatamente calda e ciononostante uscire spesso di casa con un abbigliamento inviso a ogni briciolo di buonsenso meteorologico, sudando a fiotti o sfidando la morte per ipotermia con gagliardo sorriso futurista e mani cianotiche. Regolare amministrazione autistica.
Molto tempo fa mi sono accorto di queste difficoltà senza accorgermene davvero. Ho assunto presto la consapevolezza che la mia percezione non corrispondeva alle percezione delle persone che incrociavo. Non che sia poi così difficile quando chiunque ti fa notare che una buona parte dei tuoi modi di fare e d’essere sono per così dire inappropriati, fuori luogo, strani. Dove non sono arrivato io con arguto dedurre, c’è arrivata la pressione sociale con le persuasive argomentazioni della persecuzione fra pari; anche fra dispari, vista l’annosa abitudine delle persone dotate di un potere ad abusarne. Lezione appresa. Diverso non si può, trovarsi in una brutta situazione è un crimine imputabile anche se non è un crimine e anche se non è stato commesso. I bravi bambini obbediscono. Io ho obbedito. Per fortuna ho quasi smesso, ora consumo solo mezzo pacchetto al giorno.
Questo livello di realtà colora tutta la mia vita, il mio stare nel mondo, come anche il cambiarlo. Lo spazio e l’agire tradizionale della politica extraparlamentare – ma anche di quella parlamentare, la quale però non ho mai vissuto e praticato, e mai accadrà – consiste in un insieme di implicite regole sociali le quali per lungo tempo ho tentato di capire e assecondare, inutilmente, quali diplomazie, narcisismi, bisogni d’appartenenza, omologazione, idiosincratiche intollerabilità di vario genere. La peggiore pretesa è però la straziante richiesta di abdicare la propria persona in favore di un’abnegazione totale, noncurante delle priorità, delle limitazioni e delle necessità individuali e sociali, figlia quell’idea assurda e reazionaria che è l’indipendenza: essere isole, che si sanno bastare da sole o che in questo modo amano raccontarsela; questa indipendenza, che non rappresenta le abilità legate all’autonomia personale, ma il cerotto applicato su quell’esigenza palpabile che sono i nostri rapporti di interdipendenza reciproca, in termini di affetto, di cura, di soddisfacimento dei bisogni più e meno elementari; viene chiesto insomma di favorire fatica e intelletto a un gruppo, un collettivo, una rete – esattrici di lavoro emotivo che non ne restituiscono altrettanto – che sì, fornisce una forma primitiva, grossolana e distruttiva di supporto, ma soltanto a chi possiede la possibilità e la pazienza di farne porta e soltanto a costo di distruggerl* pian piano, spogliandol* infine del diritto alla sopravvivenza in nome di qualcosa di più grande, così grande da inghiottire contraddizioni, idiosincrasie, umanità. Che libertà è mai questa? Che giustizia porta con sé? La libertà di farsi tiranneggiare da una comunità terribile, più fascista di quella che ci mette i piedi in testa di solito. La giustizia, quella delle forche.
Sono qui, diversi anni dopo, a fare i conti con quei lasciti, con l’eredità sostanziale della mia storia e delle mie peculiarità metà neurologiche, metà esistenziali. Stavolta ho con me dei fortunati incontri, una sviluppata capacità di scomporre ai minimi termini le verità che mi vengono proposte, una scarsissima pazienza per le stronzate. Sono capace, oggi, di difendere il bambino che ero e quello che c’è ora nell’uomo che sono: disincantato, umorista, consapevole, un pizzico stronzo, eppure così ostinato in una volontà sconfinata di cercare e offrire tenerezza. La vulnerabilità è un bene incedibile che si tiene in salotto per tutta la vita, un grazioso soprammobile. Non è un compito semplice prendersene cura. Quando mi serve aiuto, e mi serve, non so chiederlo mai e anzi mi accartoccio su me stesso, m’isolo e taccio. Questa è la difficoltà di sentirsi in difficoltà: avere bisogno di aiuto e non sapere come, se, quando chiederlo, a partire dalla posizione più scomoda che si possa assumere che però è l’unica possibile: o si chiede aiuto, o si continua a soffrire. Ma interpellare qualcun* è invitarl* nella mia dimora figurata; nel farlo chiamo implicitamente questa persona a passare di fronte al delicato oggettino di cristallo. Lei potrebbe accorgersi della sua presenza, decidere di toccarlo e farmi fremere nel timore che possa urtarlo, per sbaglio se non per volontà, e farne mille pezzi. Una paura non banale che si mostra nella mia tendenza così consolidata a ironizzare su assurdità, insensatezze, talvolta disgrazie e tenere distanti da sé le spiacevolezze e non averci a che fare. Una strategia ridanciana di stupidità emotiva, e per fortuna non ancora una pessima abitudine che rischia di estendersi ai problemi altri, minimizzandoli. Così ora, quando mi chiedono come va, quella frase curiosa, un’affermazione che sembra una domanda – con tutte le sue aspettative di risposta lineare e affermativa, autoconclusoria: tutto bene, grazie – mi sforzo di rispondere nel modo giusto. Una merda. Perché bisogna sapere che stare male è legittimo e la protesta anche di più. Perché la frustrazione de* singol* sia la rabbia di tutti e tutte.