La parola è un campo di battaglia
di Elisabetta Teghil
La parola è un campo di battaglia a cominciare dallo stravolgimento che se ne fa.
E’ ricorrente l’uso, nel lessico politico, di termini che si impongono senza che ne sia data una definizione preliminare ed, altre volte, con un significato completamente diverso da quello del passato.
E’ questo il caso di parole come “riforma”, “sicurezza”, “modernizzazione”….. che hanno assunto un significato completamente diverso ed ,anzi opposto, a quello che hanno avuto per un secolo e mezzo.
Le riforme di cui parlano hanno tutte carattere reazionario: quella del mondo del lavoro è la trasformazione della precarietà da fatto eccezionale a condizione normale e normata, quella dello stato sociale significa abolizione delle tutele e svendita dei servizi al privato, i nuovi rapporti padronato –lavoratori/trici significano la rinuncia alla contrattazione collettiva e l’introduzione del rapporto personalizzato con il datore di lavoro .
L’attacco alle libertà personali, alla libertà di scelta, all’autodeterminazione è a tutto campo.
Le scelte neoliberiste di controllo totale delle esistenze si esplicano dovunque.
Tutto avviene attraverso due passaggi complementari: da una parte la demonizzazione di ogni forma di resistenza al neoliberismo – lavoratori pubblici fannulloni, operai scansafatiche, insegnanti rubastipendio, pensionati parassiti, politica sporca, partiti corrotti, collettivi e centri sociali covi di terroristi ed estremisti, resistenti della Val Susa irragionevoli e violenti, solidali contro i Cie istigatori e fomentatori di rivolta, “forconi siciliani” mafiosi, disoccupati napoletani camorristi, pastori sardi malavitosi – dall’altra la promozione delle associazioni di categoria, delle ong, delle onlus, elevate al rango di una fantomatica società civile con cui dialogare.
Sostituendo i lavoratori e le lavoratrici e le loro forme di rappresentanza, la conflittualità e la lotta di classe vengono rimosse, l’impegno politico e l’ideologia annullate, così quest’ultima rimane monopolio esclusivo della borghesia neoliberista.
E rinominando le guerre neocoloniali con il termine di “umanitarie” si ottengono due risultati: presentare l’occidente come democratico, difensore dei diritti umani sul fronte esterno e strumentalizzare la violenza razzista, sessista e sulle diversità sul fronte interno.
Poi c’è l’uso selettivo delle parole.
Tutti quei governi che, per un motivo o un altro, si sottraggono alla logica colonialista che consiste nel dettare l’agenda politica e nel sottrarre le ricchezze, sono etichettati come “regimi”. Altri termini che potrebbero sembrare neutri per l’utilizzo che ne viene fatto prendono un connotato negativo, per esempio “raìs”, sostantivo che viene utilizzato per quei dirigenti del mondo arabo che sono asimmetrici agli interessi occidentali. Per i paesi sudamericani si utilizza il termine “caudillo” e, magari, “populista”.
“Genocidio” e “feroce dittatura” sono un marchio itinerante che viene applicato sempre nei confronti di tutto quello che entra ,in qualche modo in contrasto con gli interessi occidentali. Tra l’altro banalizzando, per l’uso inflazionato e strumentale che se ne fa, il genocidio e le dittature.
Altri termini sono, invece, di nuovo conio e si rivelano, una volta affermati, per quello che erano fin dall’inizio : non semplici parole, ma elementi strutturanti di una costruzione ideologica.
E’ il caso dell’espressione “governance”.
Questa non è altro che una vera e propria destrutturazione delle forme attuali della democrazia rappresentativa ed è una vera e propria “privatizzazione” della decisione pubblica, iniziata con la distruzione del proporzionale, la rimozione dell’immunità parlamentare, e che sfocia in una delegittimazione del parlamento.
E’ l’affossamento di tutte le forme di resistenza al neoliberismo.
Il neoliberismo è un’ideologia e costruisce, a sua immagine e somiglianza, tutto il metabolismo sociale, avendo, come modello, la direzione autoritaria e verticale della fabbrica e dell’impresa.
E le scelte politiche che l’iper- borghesia fa, vengono celate dietro lo schermo di una presunta neutralità, necessarietà, inevitabilità.
Non ci sono zone neutre, non c’è niente che sia apolitico. Il principio femminista che il privato è politico è sempre valido ed attuale.
Tutto questo presuppone anche il rifiuto delle leggi securitarie e del controllo sociale, nonché il disvelamento dei meccanismi che opprimono e dividono buone/i e cattive/i, omologate/ e non omologate/i, “normali” e diverse/i.
Di conseguenza anche la lotta contro i linguaggi e gli atteggiamenti e i comportamenti sessisti deve essere accompagnata dallo smascheramento delle parole politicamente corrette come “convivenza civile”, “sereno confronto fra i sessi”, “affido condiviso”, “partecipazione e scelta responsabile”, “educazione alla convivenza”……. che strumentalizzano le lotte delle donne , confondono l’aggredita con l’aggressore e mettono sullo stesso piano chi la violenza la subisce e chi la esercita.
Ma se sono le parole che fanno le cose, disfare quelle parole che sono allo stesso tempo categorie di rappresentazione e strumenti di mobilitazione ha contribuito alla smobilitazione dei movimenti antagonisti, femministi e di classe.
Militanza, collettivi, impegno…..sono forme di resistenza all’ideologia neoliberista a cui non vogliamo e non possiamo rinunciare per gettare qualche granello nella macchina disumanizzante di questa società.
Mai come in questo momento serve il movimento femminista autonomo e autorganizzato, con la sua elaborazione teorica, le sue lotte e la sua lettura di genere e di classe

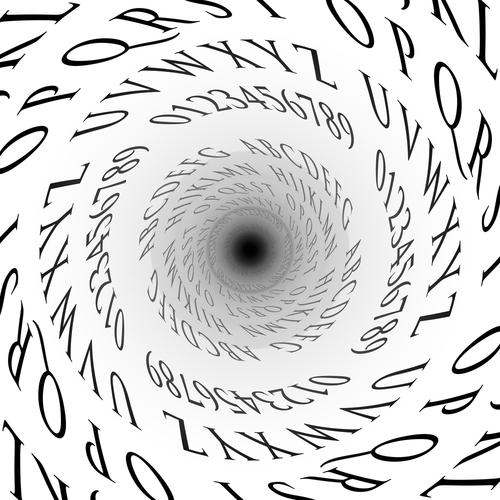







se la parola resta tale, la battaglia è già persa.