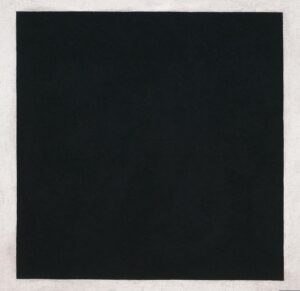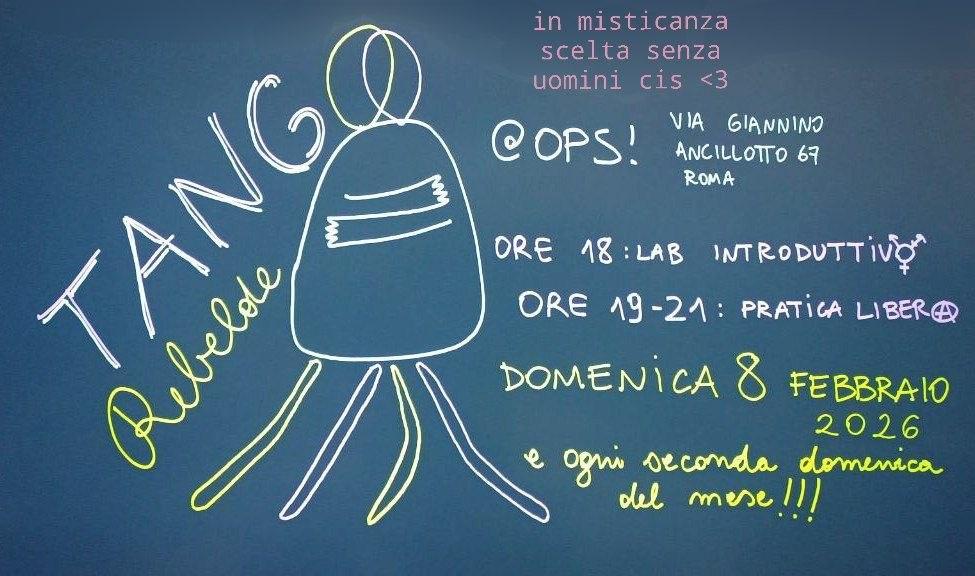Un bel testo del Comitato di Lotta Quadraro/Nido di Vespe
L’ORRORE È REALE LA LOTTA NON PUÒ PIÙ ASPETTARE.
Esplode lo scandalo Epstein dove i file desecretati comprovano l’esistenza di una rete di ricatti, stupri, pedofilia e probabilmente cannibalismo ai vertici del potere occidentale. Non sono cronache di un film dell’orrore, non sono fantasie distopiche o fake di qualche “bontempone” del web ma una tragica realtà dove le vittime sono in carne e ossa, una rete di ricatti per tenere in scacco i governi gestita dal Mossad dove sono coinvolti personaggi del calibro di Netanyahu, Barak, Trump e molti altri fervidi sostenitori del genocidio ai danni del popolo palestinese, assoggettati alle politiche criminali di Israele.
I media mainstream bipartizan mettono avanti la mani trattano questa infamia con indifferenza, come uno dei tanti scandali sessuali che circondano la vita di ricchi borghesi annoiati, giocano la loro carta migliore cioè l’incredulita’, alzando l’asticella della vergogna manipolando la realtà al punto di farci sorgere dubbi sulla veridicità, eppure la realtà ha superato abbondantemente la nostra peggiore immaginazione. Il caso Epstein non è soltanto un’infame caso di violenza pedo-sessuale ma un’operazione di spionaggio e ricatti dove quei bambini non sono attori, dove quei palazzi del potere non sono un set cinematografico, il mostro è reale e tangibile e siede nella stanza dei bottoni ed è da lì che i balordi concepiscono le azioni più aberranti come lo sterminio del popolo palestnese, l’invasione di terre, guerre, bombardamenti, massacri indiscriminati in nome del “Dio profitto”,e mentre ci rifugiamo nel dubbio lorsignori continuano controllare il mondo massacrando innocenti, ricattando popoli , preparando operazioni belliche che nel migliore dei casi ci condurranno ad un conflitto senza precedenti.
C’è una domanda che assilla le donne e gli uomini che non hanno ancora barattato la propria dignità in cambio di una fittizia e pelosa tranquillità, che non si sono lasciat# lobotomizzare dalle narrazioni mainstream e dall’utilizzo pernicioso della tecnologia: PERCHÉ NON STIAMO ANCORA BRUCIANDO DI RABBIA?? Eppure la rabbia quella vera, costruttiva, genuina è una reazione sana e pulita da contrapporre al sistema, ai palazzi del potere, agli alfieri della logica del profitto. Non possiamo più tacere davanti alle nostre condizioni di sudditanza, di sfruttamento, intimidazioni e repressione, dobbiamo organizzarci e combattere lo stato di cose presenti, il futuro non è garantito.
COMITATO DI LOTTA QUADRARO