E questo è quanto
di Silvia De Bernardinis
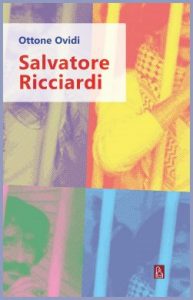
“E questo è quanto. Storie di rivoluzionarie e rivoluzionari”. Il titolo della nuova collana edita da Bordeaux e curata da Ottone Ovidi esordisce con questo primo volume dedicato a Salvatore Ricciardi. Una storia e una vita di militanza, iniziata nelle piazze, con le grandi manifestazioni contro il governo Tambroni nel 1960 e la rivolta degli edili a Piazza SS. Apostoli nel 1963, stesso carattere e stessi contenuti della più nota Piazza Statuto torinese dell’anno precedente, uno snodo importante che comincia a dare fisionomia ad una nuova soggettività operaia, quella che farà da traino e sarà il collante del movimento di classe che emergerà chiaramente durante il biennio 68-69. La crescita politica di Salvatore, come lui stesso racconta, avviene nel contesto di queste lotte operaie, prima con gli edili e poi, soprattutto, nelle ferrovie, dove svolge attività sindacale nella Cgil e successivamente, cacciato dal sindacato, nel Cub-ferrovieri, di cui è uno dei fondatori. Sono gli anni, quelli tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta, che sanciscono il passaggio dalla non ostilità alla rottura con la sinistra istituzionale, ed in particolare con il Pci, che nel corso degli anni 70 diventerà sempre più profonda. Nel 1977, l’entrata nella colonna romana delle Brigate Rosse. Sarà arrestato nel 1980, e come tutti i prigionieri politici sperimenterà il circuito delle carceri speciali e l’ultima grande rivolta carceraria, quella di Trani che, legata al contemporaneo sequestro D’Urso, porterà alla chiusura dell’Asinara. Ultima battaglia unitaria delle BR, dopo la quale si consumerà la scissione dell’organizzazione, diretta dall’interno del carcere, con la formazione del Partito Guerriglia al quale, diversamente dalla maggioranza dei prigionieri politici BR, Salvatore non aderirà. È un processo, questo che porta alla scissione, che Salvatore vive in parte fuori e in parte dentro il carcere, che inizia nel 1979 con una dura critica dei prigionieri politici all’Esecutivo, espressa attraverso le 20 tesi del “documentone” elaborate nel carcere di Palmi, con le quali si accusava l’organizzazione all’esterno di incapacità di innalzare lo scontro sociale e guidare un movimento che si immaginava, astrattamente ed erroneamente, fosse all’offensiva. La realtà, come era evidente all’esterno e come ricorda Salvatore che fino al 1980 la sperimenta nella pratica, era invece quella di un movimento alle corde, che doveva fare i conti con la repressione e con la ristrutturazione produttiva che avanzava. Del resto, dice Salvatore, il carcere è fatto per tagliare fuori dalla realtà, e l’unico conflitto che si può praticare è quello carcerario. Dopo trenta anni, sarà definitivamente libero.
Nell’introduzione Ovidi espone in modo chiaro le motivazioni e gli obiettivi del suo lavoro, un lavoro militante: uno strumento per contrastare la perdita della memoria delle classi subalterne, delle loro pratiche e del loro sapere, e riannodare il filo rosso di una memoria storica di classe reciso con la sconfitta dei movimenti rivoluzionari del XX secolo, affossato sotto l’inganno della fine della storia, base ideologica del neoliberismo e della postmodernità, che ha progressivamente espunto dall’orizzonte politico contemporaneo e dalla Storia, il concetto di conflittualità, depoliticizzando e passivizzando, nel presente, i soggetti che fanno la storia, e poi espropriandoli della propria storia.
Il conflitto, che è alla base dei processi storici, è progressivamente scomparso dalla narrazione storica, sostituito, in una prospettiva che si può definire di giudiziarizzazione, dalla narrazione di memorie che riproducono e riducono la storia ad un permanente scontro tra carnefici e vittime, tra bene e male, dove – è sottinteso – il bene e le vittime coincidono con i valori che si impongono come dominanti, e che lo sono proprio perché risultato di rapporti di forza politici e sociali determinati dall’esito di conflitti. Il terreno di ricerca scelto da Ovidi, privilegiando in questo caso la memoria, una memoria contrapposta, di classe e militante, è uno dei migliori punti di osservazione per portare in luce l’uso politico del passato nella costruzione del presente e di scrittura della storia compiuta su questo terreno, per metterne a nudo il feticcio della presunta neutralità.
La scelta di ripercorrere quell’ultimo scontro sociale che ha chiuso un ciclo, un mondo e un secolo nel racconto che ne restituisce chi è stato e continua ad essere stigmatizzato come carnefice, è importante perché è una voce che contrasta con la normalizzazione di un periodo storico compresso sotto etichette che, pur rivelandosi alla luce della ricostruzione storiografica vuoti involucri propagandistici, sono penetrati nel senso comune. Il quadro che ne emerge è di segno contrapposto a quello dei i cupi e insanguinati anni Settanta che è stato imposto come dominante.
Quella di Ricciardi è una storia significativa non per la sua eccezionalità ma, al contrario per la sua comunanza con le migliaia di altre storie che hanno attraversato lo stesso periodo, perché, pur non avendo tutti compiuto l’identico percorso, incarnano, come giustamente dice Ottone Ovidi, lo spirito di un determinato tempo storico. Parliamo di un ventennio che è stato una sorta di terremoto che ha aperto crepe dalle quali è fuoriuscita una molteplicità di espressioni di insubordinazione all’esistente, dal basso, proprio come da una crepa sulla terra, che ha fatto emergere soggettività fino ad allora invisibili o marginali. Non solo operai, studenti, ma anche il proletariato extralegale, i carcerati, addirittura i “pazzi”, nascosti nei manicomi, riuscirono ad acquisire visibilità, a farsi soggetto. Un sommovimento provocato dalle stesse dinamiche del capitale in trasformazione, dalla crisi fordista nell’occidente capitalistico, una conformazione sociale nuova che non incontra e non si incontra nelle forme di rappresentanza politica tradizionali. Una visione della politica come esperienza totalizzante e collettiva e una percezione, anch’essa collettiva, di poter ribaltare, su qualunque piano, lo stato di cose esistenti. Questo è il quadro nel quale si inserisce l’esperienza politica di Salvatore Ricciardi. Il suo racconto si snoda sul filo della memoria, e dunque non segue un preciso ordine cronologico. La memoria seleziona, è personale, non sempre precisa, e rielabora il passato alla luce e in base alle necessità e ai desideri del presente, enfatizzando alcuni particolari del passato e obliandone altri. Sta poi allo storico verificarla, incrociarla con altre fonti, compararla, interpretarla all’interno del suo contesto. Ma la testimonianza rimane comunque una fonte essenziale, laddove è possibile raccoglierla, per la ricostruzione storica. È materia viva e pulsante, quella che dà concretezza e mostra la vita di cui si nutrono i processi storici. In questo caso specifico, potremmo dire, la vita, le pulsioni, le passioni, i conflitti, che la lettura di altri fonti documentali fondamentali, come lo sono ad esempio le Risoluzioni strategiche, non riescono a restituire. Proprio attraverso questo tipo di lavoro, che ricostruisce il contesto politico e sociale del percorso dei militanti delle BR, del tutto inserito all’interno delle lotte del periodo, crolla la mostrificazione creata ad hoc su di loro. Una mostrificazione che, sotto le diverse etichette di volta in volta assegnate – dai folli omicidi isolati dalla società, agli infiltrati, agli sciocchi eterodiretti – serve a coprire il vero nervo scoperto di quel periodo storico, e cioè, la messa in discussione, pratica e teorica, del monopolio della violenza dello Stato da parte delle classi subalterne.
Uno dei temi che attraversa il libro, e che costituisce uno dei possibili fili della memoria da riannodare, è quello della solidarietà di classe che, come dice Salvatore Ricciardi riferendosi al contesto di oggi, non può essere evocata astrattamente, ma è sempre risultato della pratica di lotta e dei rapporti che in essa si costruiscono. Una solidarietà di classe che Salvatore racconta parlando del legame stretto con la generazione successiva alla sua, dell’alleanza tra studenti e operai, della condivisione e trasmissione di esperienze di lotta, così come la sua generazione l’aveva avuta con la precedente, che veniva dalla Resistenza. Una solidarietà di classe ricordata attraverso il ricorso diffuso a pratiche illegali – altro concetto, quello dell’illegalità, completamente cancellato dalla storia delle classi subalterne negli ultimi decenni – con le quali i lavoratori si soccorrevano reciprocamente. Ed una solidarietà, durante la militanza nelle BR, che si esprime per un lato attraverso il rifiuto alla delazione nei confronti dei militanti BR, promosso in primo luogo dal PCI; per altro lato, attraverso un aperto consenso rispetto alle azioni BR, ogni volta che nelle fabbriche si colpivano i capi, o nei quartieri proletari figure particolarmente invise ad essi, a dimostrazione di quanto l’organizzazione non fosse isolata rispetto alle dinamiche del movimento e della classe operaia. A questo proposito, Ricciardi riconsiderando ex post questo consenso, lo definisce un “consenso tifoso”, e cioè, dice, fu all’epoca scambiato – commettendo con ciò un grave errore – per disponibilità a partecipare, seppur non attraverso l’adesione alle formazioni armate, ai diversi terreni di scontro di classe, dando la percezione che si potesse accelerare nello scontro. C’è infine una solidarietà tra proletari che Ricciardi sperimenta nella sua esperienza all’interno del carcere e tra il carcere e l’esterno, e che certamente si rafforza con la crescita della presenza dei prigionieri politici. Una solidarietà di classe che in ogni caso si crea nelle pratiche collettive del conflitto capaci di modificare – quando si saldano attorno ad un progetto di cambiamento dell’esistente – i rapporti di forza tra classi, come è accaduto in quegli anni, seppur per una breve fase. Appropriato, a questo proposito l’esempio fatto da Salvatore riguardo all’articolo 18: “non è l’articolo 18 che difendeva dai licenziamenti, era il rapporto di forza interno alla fabbrica che ha prodotto l’articolo 18, non il contrario. Il padrone non riusciva a licenziare perché se ci provava succedeva un gran casino”
Un passaggio dell’intervista richiama in particolare l’attenzione, e cioè la lettura ex-post dell’azione più nota della Campagna di primavera, l’”operazione Fritz” reinterpretata come scelta dettata dall’incalzare del movimento del Settantasette che, dice Ricciardi, nella sua radicalizzazione, impone un’accelerazione a tutto il movimento, armato e non. Come è noto, il percorso che portò alla Campagna di primavera del 1978 aveva le sue origini nell’attacco al cuore dello Stato, che almeno dal 1974 – proprio per contrastare il rifluire del movimento nelle fabbriche e per la presa d’atto che su quel terreno non era possibile avanzare oltre quanto già fatto – costituiva la linea delle BR, in modo tra l’altro molto netto, e differenziandola dalle altre organizzazioni combattenti. Questa lettura di Salvatore, più che “non piacere ai teorici classicheggianti del marxismo-leninismo”, per riprendere le sue parole, non trova corrispondenza nelle fonti documentali – intese nel loro senso più lato – che ricostruiscono il dibattito del periodo e dalle quali si ricava che le BR non interagirono con il movimento del Settantasette, profondamente diverso per istanze e per composizione, e che fu tra l’altro una fiammata concentrata in alcune città. Vi furono alcuni segmenti, all’interno di quel movimento che guardavano alle BR (basti ricordare il Convegno di Bologna). Ed infatti, ciò che si verificò, dopo il 1978, quando già il movimento si era esaurito, fu la richiesta di molti di coloro che ne avevano preso parte, di entrare nelle BR – e le richieste furono attentamente filtrate proprio per le differenze politiche di cui questi militanti erano portatori.
È importante questo libro e questo progetto perché contribuisce – unendosi ad altri testi pubblicati in questi ultimi anni, tanto sul piano della memorialistica che su quello storiografico – a mettere in luce una prospettiva diversa sugli anni Settanta e sulla lotta armata. Infatti, quanto più si amplia e si approfondisce lo studio del contesto sociale del periodo, delle storie, dei percorsi politici dei militanti, tanto più cadono i luoghi comuni entro cui tutta quella stagione di lotte è stata stretta. Certo, si tratta di una prospettiva minoritaria, che fatica ad emergere, perché deve fare i conti, soprattutto, con rapporti di forza attuali che non sono favorevoli, perché anche la memoria e la storia sono campi di battaglia. Perché, come dice giustamente Ovidi, il modo di scrivere la Storia non è mai neutrale, anche se, in modo niente affatto innocente, così viene presentato. Come se la ricerca, la selezione e la ricostruzione storiografica a partire dalle fonti documentali, non fossero risultato di scelte di parte, come se lo stesso storico potesse essere neutrale rispetto alla ricerca. E su questo le classi dominanti hanno lavorato e lavorano incessantemente. Il liquidare e relegare la storia delle organizzazioni armate a fenomeno criminale o a trama ordita da forze oscure; imporre, così come è stato fatto negli ultimi anni, l’”invenzione” della memoria collettiva condivisa, che è di fatto memoria di stato, è un modo per espropriare la memoria dei dominati, perché si percepiscano senza storia, con la conseguenza di ritrovarsi a ricominciare ogni lotta dall’inizio, come fosse la prima, come se non avessero un passato collettivo. Proprio qui sta l’importanza di riprendere quel filo rosso spezzato, connetterlo all’oggi, farne uno strumento di riattivazione della trasmissione di esperienza, di conoscenza e di recupero di saperi e pratiche che fanno parte della storia di classe, che certo non posso riproporsi per i cambiamenti epocali intervenuti, ma che possono aiutare a capire – ed è qui, soprattutto, il dato più importante – su quali limiti le potenzialità espresse da quel ciclo di lotte si sono incagliate.







